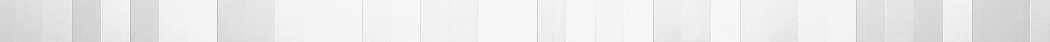Il kimono è l’indumento tradizionale del Giappone, ne esistono modelli femminili e maschili. La sua storia affonda nelle radici della cultura del sol levante. Il termine kimono viene utilizzato per indicare un indumento tradizionale giapponese, costituito da una lunga tunica incrociata dalle ampie maniche e legata da una fascia in vita. Caratteristica estremamente particolare di tale veste è quella per la quale il lembo sinistro viene sempre posto al di sopra di quello destro in tutte le occasioni tranne che ai funerali, ove avviene l’inverso a guisa di simbolo.
Origini
Il sostantivo kimono (o, italianizzato, chimono) è stato sottoposto ad una notevole evoluzione. Basti pensare che, in origine, esso veniva impiegato per indicare in senso generico ogni tipo di abito. Solamente in una fase successiva il suo significato si è evoluto, arrivando ad indicare la lunga tunica di cui sopra, indossata da persone di ogni età e sesso, sebbene a tal riguardo sia interessante richiamare all’attenzione la figura del furisode, ossia un particolare tipo di kimono indossato dalle donne nubili avente lo scopo di palesare, nell’ambito del Seijin shiki (la cerimonia che segna il passaggio alla vita adulta), la disponibilità della donna a contrarre matrimonio.
Eccettuando le primissime fasi, influenzate prevalentemente dalle tradizioni del popolo cinese degli Han nel IV secolo, la storia del kimono è un po’ quella delle numerose dinastie giapponesi. Dall’VIII secolo in poi, infatti, il costume divenne popolare anche in Giappone con alterne fortune:
Tra l’VIII ed il XII secolo si compì l’evoluzione maggiore del kimono, che divenne enormemente simile a quello attuale, seppur ricoperto dal mo, una sorta di ampio grembiule;
I secoli tra il XIV ed il XVI, invece, portarono alla ribalta il kosode, ancora considerato un capo di abbigliamento intimo più che di vestiario vero e proprio, ma comunque degno di menzione, in virtù dell’utilizzo di una cintura, poi non più abbandonato;
In ultima analisi, praticamente analoga rispetto a quella odierna è la conformazione che la veste tradizionale giapponese assunse durante il periodo Tokugawa, o periodo Edo, compreso tra il XVII ed il XIX secolo. In questo arco temporale, infatti, si assiste ad un allargamento delle maniche e all’inserimento di una varietà di nodi sempre più elaborati.
Come è fatto il kimono
Molto somigliante ad alcuni indumenti in voga in Cina nel corso della dinastia Tang, è una veste lunga fino alle caviglie, con grandi colletti e maniche lunghe e molto ampie: possono infatti raggiungere il mezzo metro se non addirittura arrivare a sfiorare terra (questo tipo di manica si chiama fuorisode) nel caso dei modelli indossati tradizionalmente dalle ragazze nubili. La veste viene invece avvolta attorno al corpo con la parte sinistra che va a coprire la parte destra, a meno che non si debba presenziare a un funerale, nel quale caso la disposizione dei lembi viene invertita.
Una grande cintura chiamata obi serve, infine, a fissare la veste al corpo. Esattamente come succede da noi, anche in Giappone ogni occasione, dall’incontro formale alla riunione di famiglia, vuole il suo kimono; ne esistono infatti di diversi tipi, anche se sostanzialmente la forma rimane invariata, soprattutto nel caso di quelli da uomo che sono caratterizzati anche da una gamma di colori molto sobri e poco appariscenti. Nei modelli da donna invece il grado di eleganza e di formalità viene definito dalla lunghezza delle maniche, dal tipo di stoffa utilizzata, dalle cromie degli accessori e dalla presenza o meno dei kamon, gli stemmi familiari.
Mentre i modelli maschili vengono creati in varie taglie, quelli da donna per tradizione sono sempre taglia unica, leggermente più lunghi dei modelli maschili per essere adattati al corpo con rimbocchi e piegature che permettono di adattare ampiezza e lunghezza; un kimono che secondo la tradizione deve arrivare alle caviglie nel caso dell’uomo ci arriva senza piegature, nel caso della donna può essere ripiegato sotto l’obi in una piegatura chiamata ohashori.
I modelli tradizionali sono ancora oggi realizzati come centinaia di anni fa, ossia ricavandoli da un tan, un unico rotolo di tessuto largo 35 cm e lungo 11,5 m. È questo il motivo per cui realizzarlo di taglie grandi risultava complicato e dispendioso, ad esempio per persone molto alte oppure quelle corpulente come potevano essere i lottatori di sumo, che infatti avevano bisogno di modelli realizzati ad hoc per le loro forme abbondanti.
Un kimono ‘finito’ quindi è un insieme di 4 larghe fette di tessuto, delle quali due vanno a coprire il corpo e due vengono utilizzate per le maniche, più due strisce un po’ più piccole che diventeranno il colletto e i risvolti frontali dell’abito. Questo particolare tipo di assemblaggio dei tessuti permetteva, soprattutto in passato, di scucirlo per lavare una a una le varie parti, cosa che ormai grazie alla modernizzazione sia dei tessuti che dei metodi di pulitura non è più necessaria. Mentre ancora oggi, come in passato, si usa imbastire gli orli di un kimono che non deve essere indossato per un lungo periodo per evitare antiestetiche piegature e per mantenere le diverse parti dell’abito correttamente allineate.
Spesso paragonabili a vere opere d’arte, questi abiti tradizionali sono ancora realizzati a mano con tessuti preziosi, anch’essi decorati a mano con motivi unici o con texture ripetute. Sono diversi, i modi di decorazione; uno dei più diffusi è senza dubbio lo yuzen, una tintura a base di pasta di riso che viene ‘ripetuta’ a intervalli regolari utilizzando la tecnica dello stencil o con una fustella. Ovviamente, con il passare del tempo, se la tecnica è rimasta pressoché identica, si sono invece evoluti i colori, gli stili, i tessuti e gli accessori, ad esempio l’obi. La tradizione vuole infatti che kimono e obi siano realizzati in seta, satinato o broccato, mentre i kimono dei nostri giorni sono realizzati anche con tessuti più economici e resistenti, ad esempio in cotone, poliestere o rayon. Nonostante questo però la seta è comunque considerata il tessuto d’elezione, soprattutto nelle occasioni informali, dove diventa praticamente d’obbligo. E se oggi sotto a un kimono solitamente si indossa una speciale sottoveste, nei secoli passati andava a coprire più e più strati di indumenti.
Kimono da donna
Indossare questo indumento non è impresa da poco, soprattutto per le donne, i cui kimono sono molto più elaborati di quelli maschili; basti pensare che il modello femminile è composto da un minimo di 12 componenti che vanno indossate in un ordine e con regole ben precise. Non per niente sono presenti ancora oggi figure professionali con tanto di licenza il cui compito è proprio quello di aiutare le donne a indossarli, sia nei parrucchieri che a domicilio. Queste ‘assistenti’ spesso aiutano anche le donne a scegliere quello giusto per l’occasione, che sia adeguato alla formalità dell’evento a cui presenziare, allo stato civile e all’età. Ecco alcuni esempi:
Kurotomesode
Risulta essere la veste ufficiale delle donne già sposate e spesso viene indossato ai matrimoni dalla futura suocera. Di colore rigorosamente nero e decorato solo nella parte inferiore, è caratterizzato dalla presenza di cinque stemmi di famiglia che vengono impressi davanti, dietro e sulle maniche.
H mongi
La traduzione letteraria dal giapponese è ‘abito da visita’; può essere indossato indifferentemente da donne sposate e non, solitamente in occasione di eventi particolarmente formali o, ai matrimoni, dalle amiche della sposa. È decorato anche sulla parte superiore delle spalle.
Edo komon
Il suo nome deriva dall’inconfondibile stile decorativo in cui raggruppamenti di tanti puntini finiscono per creare un disegno più grande, una tecnica tipico della classe dei samurai del periodo Edo. Il suo livello di formalità può essere considerato al pari di quello di un iromuji e, in caso sia decorato anche con stemmi familiari, può equivalere a un h?mongi e volendo anche a un tsukesage.
Yukata
Sfoderato e creato con tessuti non ‘nobili’ come la canapa, il lino o il cotone, è il più informale dei modelli, indossato generalmente in estate e in eventi all’aperto. Spesso sono anche dati agli ospiti delle strutture termali.
Tsukesage
Può essere visto indosso a donne nubili o sposate; non è molto decorato e solitamente i ricami e i disegni si trovano sotto la cintura e nelle maniche.
Iromuji
Lo può indossare qualsiasi donna e solitamente è destinato alla cerimonia del tè. In tinta unita e di qualsiasi colore escluso il nero, il bianco e l’avorio, è in seta tinta decorata in quello che da noi verrebbe definito uno stile jacquard, rigorosamente dello stesso colore dell’abito.
Furisode
La traduzione letteraria del termine è ‘maniche svolazzanti’; le sue maniche, molto lunghe, possono arrivare fino a un metro e oltre di lunghezza, e proprio in base a questa lunghezza, cambia anche il nome: kofurisode, con maniche di 75 cm, il chuburisode con maniche di 90 cm) e fino a 114 cm di manica per il l’burisode. Sono i kimono per le occasioni formali dedicate alle ragazze nubili, preziosi e riccamente decorati. Solitamente l’età limite per indossare un furisode è 25 anni, anche se ultimamente l’età in cui una donna va in sposa si sta spostando sempre più avanti. Questo modello viene anche indossato nelle celebrazioni di compimento della maggiore età e, in caso di matrimonio, dalle parenti nubili.
Irotomesode
Leggermente meno impegnativo del kurotomesode ma accomunato dal fatto di essere anch’esso di colore scuro (tranne il nero) e decorato solo nella ‘gonna’, viene indossato ai matrimoni dalle parenti più strette e può avere impressi tre o cinque stemmi familiari.
Komon
E’ caratterizzato da una decorazione che si ripete, come una texture, su tutto l’abito. È usato per le occasioni meno formali, ad esempio una passeggiata per strada o un invito a cena; in quest’ultimo caso andrebbe impreziosito da un obi elegante.
Complesso e prezioso, ogni modello è composto da diversi elementi. Ecco quelli del modello femminile:
Sode: la manica.
Sodeguchi: l’apertura della manica.
Sodetsuke: il foro del braccio.
Susomawashi: il fodero interno.
Doura: la fodera esteriore.
Eri: il colletto.
Fuki: l’orlo, spesso ricamato.
Furi: quella abbondante parte di manica che scende da sotto il braccio.
Maemigoro: la parte anteriore.
Miyatsukuchi: l’apertura che si trova sotto la manica.
Okumi: l’interno della parte anteriore.
Tamoto: il drappeggio della manica.
Tomoeri: la parte superiore del colletto.
Uraeri: la parte interna del colletto.
Ushiromigoro: la parte posteriore.
Kimono da uomo
Infinitamente meno complicati di quelli da donna, quelli maschili sono composti da un massimo di 5 componenti, escluse le calzature. Al giorno d’oggi, si differenziano sostanzialmente per la stoffa utilizzata e per il modello, anche se la tradizione vuole che siano di colori scuri come il nero, il blu, il verde e qualche volta anche il marrone. I tessuti solitamente non sono brillanti e la decorazione non è vistosa. Nelle versioni meno formali troviamo colori un po’ più accesi, ad esempio il blu, il verde e il viola e la possibile presenza di massimo tre stemmi, mentre quello dedicato alle grandi occasioni, è rigorosamente nero e con cinque stemmi sulle spalle, sulla schiena e sul petto. Questa sobrietà di base viene confermata anche negli accessori e nella biancheria, che sono generalmente di colore bianco.
Accessori
Kanzashi
Sono graziosi accessori per capelli, ad esempio forcine in pietra preziosa come la giada, pettinini intarsiati nel legno e coloratissimi fiori di seta.
Waraji
Sono calzature di corda utilizzate solitamente dagli appartenenti alla classe religiosa.
Z ri
Sono sandali unisex, assolutamente lisci o fittamente decorati, disponibili in diversi materiali tra cui la fibra, la pelle o in semplice tessuto.
Hakama
Assomiglia a quella una gonna-pantalone. Solitamente la usano gli uomini, anche se ultimamente l’uso si è esteso anche alle donne, e spesso viene utilizzata come componente delle uniformi delle arti marziali. L’hakama solitamente si presenta a pieghe ed è dotata di un himo, ossia lunghi drappi di tessuto che vanno ad avvolgersi attorno all’obi. In alcuni casi può presentare anche un’imbottitura o una parte rigida in corrispondenza della ‘seduta’. Non è un accessorio che viene solitamente utilizzato dalle donne nelle occasioni formali, mentre può diventare parte integrante di un kimono formale maschile.
Obi
Da noi verrebbe chiamata fusciacca, o semplicemente cintura. Viene indossata sia con il kimono che con la yukata, con diversi modi di portarlo e di fissarlo. Gli obi femminili solitamente sono più decorati.
Datejime
E’ una sciarpa quasi rigida da mettere sotto l’obi per tenerlo in posizione.
Geta
Sono sandali unisex che vengono indossati con lo yukata. Una versione di geta simile ma non uguale viene indossata dalle geishe.
Tabi
Sono calzini appositamente creati per poter essere indossati con i sandali e le infradito. In quest’ultimo caso, l’alluce è separato dalle altre dita.
Haori
Nato tra il quindicesimo e il diciassettesimo secolo, è una specie di soprabito che arriva fino a metà gamba, e che fino ai primi anni del novecento, fine dell’epoca Meiji, faceva parte dell’abbigliamento maschile. Successivamente è entrato a far parte anche della moda femminile, in una versione leggermente più lunga.
Hiyoku
Chiamatelo pure sottoveste, o sottokimono; oramai si indossa solamente ai matrimoni o ai grandi eventi.
Haori-himo
Risulta essere una corda decorata con piccole nappe che serve a stringere l’haori. Solitamente nelle occasioni formali il colore d’elezione è il bianco.
J nihitoe
Anticamente veniva indossato dalle dame di corte, oggi è una specie di cimelio della tradizione che viene sfoderato solo nelle occasioni davvero speciali quali un’incoronazione o un matrimonio imperiale. Visionabile nei musei, è un complicato abito composto da 12 strati.
Molto interessante.